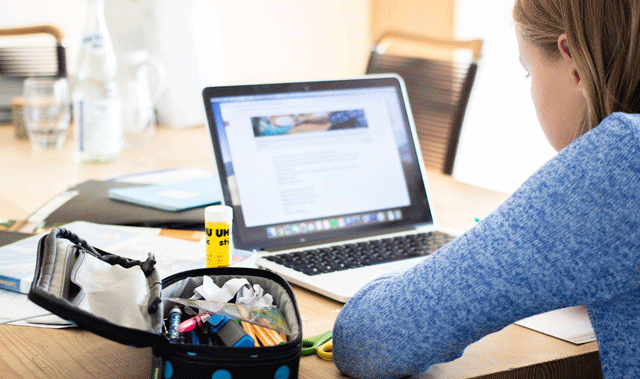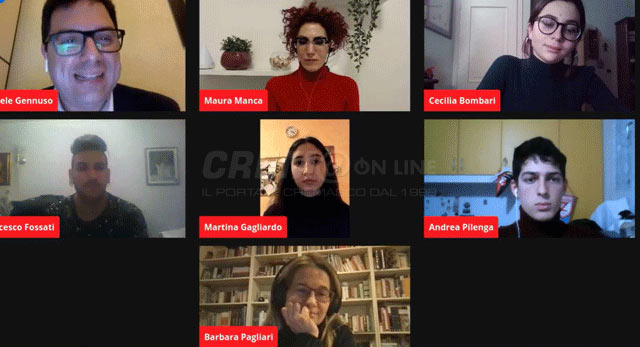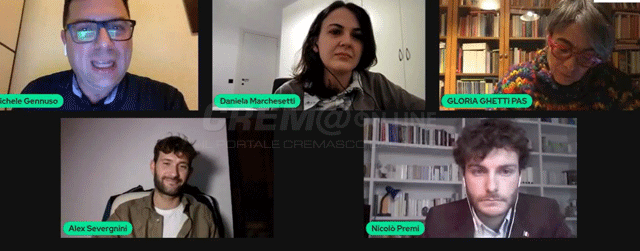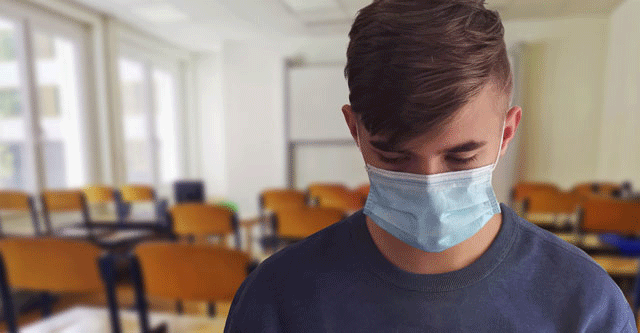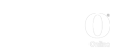La scuola deve ripartire dall'ascolto delle emozioni. “Deve fare ricerca, innovare, formare, partecipare ed osare”. Questa, in estrema sintesi, la conclusione della docente Elisabetta Musi al termine del convegno organizzato dall'Università Cattolica di Cremona con l'intento di commentare e riflettere circa i risultati dell'indagine promossa dall'Ust di Cremona per indagare l'impatto della pandemia sulla psiche, l'emotività, la socialità ed i comportamenti degli adolescenti. Lo studio, condotto dal docente cremasco Alex Severgnini in collaborazione con la collega Elisabetta Ferrari e gli esperti dell'università Cattolica del Sacro Cuore, è stato sostenuto dall'allora provveditore Fabio Molinari. Ha coinvolto 2699 studenti della scuola secondaria di primo grado e 6306 della scuola superiore. E ha fatto capire che “per quanto il sistema scolastico abbia tenuto, vi è comunque un grado di disapprovazione da parte dei giovani, che non può non essere considerato”.
Prendersi cura delle emozioni
Partiamo dalla Dad: “circa il 30 per cento si dichiara non soddisfatto di come sono state organizzate le lezioni”. Il dirigente scolastico dell'Ic Crema due Pietro Bacecchi prova a fare alcune ipotesi. Tra i motivi, sicuramente spiccano “i problemi tecnici, l'indisponibilità dei mezzi, la mancanza di interattività, la mancanza del sostegno fisico dell'insegnante”. Di contro però “la didattica a distanza ci ha consentito comunque di esserci. Di andare avanti, di intraprendere una didattica della vicinanza, di una nuova vicinanza. Senza, i giovani sarebbero stati condannati ad un isolamento profondo. Ci ha consentito di ripensare la scuola come luogo di socialità, come luogo di relazione”. Anche se per alcuni (non pochi per la verità), la scuola fatta di banchi e fisicità non era nel periodo dell'emergenza sanitaria “un luogo sicuro”. La pensa così il 15,3 per cento degli alunni delle scuole medie ed il 33.5 per cento degli studenti delle scuole superiori. “Anche per questo, si è assistito ad un rafforzamento della coesione familiare” come unico antidoto all'isolamento. Quel che è chiaro è che la scuola non può restare ferma “deve utilizzare la vulnerabilità per promuovere la resilienza a partire dai nuovi bisogni emersi”. Tra questi, quello della continuità: “dopo un punto di rottura ciascuno di noi deve ricostruire una routine”. Quello di ascolto e comprensione: “tutti abbiamo bisogno di rinascere. La continuità emotiva deve tenere il passo a quella didattica. La scuola deve aiutare i giovani a riscoprire le emozioni, impartendone la cura e assegnando compiti di realtà. L'accoglienza emotiva deve diventare lo strumento bussola per capire e cavalcare la tempesta”. I giovani devono “poter coltivare ancora il bisogno di appartenenza ad un gruppo classe e devono essere guidati verso l'interiorizzazione delle nuove regole”.
Dispersione
“Secondo i dati diffusi dal quotidiano Avvenire” interviene la preside del Galilei Paola Orini - la dispersione scolastica riguarda dall'emergenza pandemica 10-16 milioni di ragazzi in più”. Si tratta di giovani persi, che non hanno maturato uno sviluppo delle competenze adeguato o che hanno rinunciato agli studi. Una piaga percepita anche dai giovani cremonesi, dal 30 per cento circa. Determinata pure dalla mancanza di mezzi adeguati: “il 12 per cento nella scuola secondaria di primo grado ed il 12,4 degli alunni delle scuole superiori avevano a disposizione uno smartphone”. Sul deficit d'attenzione, o sempre più spesso su una mancata connessione, incidono anche nuove abitudini di vita: “durante il lockdown il 14 per cento del campione ha dichiarato di andare a dormire dopo l'una di notte”. Sono state modificate anche le abitudini alimentari, a vantaggio del cibo spazzatura. La dad “va oltre la nostra normale modalità di concepire la scuola. Spesso ha portato ad un uso abnorme e smodato di strumenti tecnologici. Ciò non toglie che in una situazione emergenziale come questa si sia rivelata uno strumento utile e necessario. Per non perderci del tutto. Non mi sento di demonizzarla in toto, credo possa essere impiegata anche in situazioni ordinarie in determinati contesti. Certo, andrebbero ripensati tempi, modi e strategie”.
La paura del domani
Come ha spiegato la senatrice Vanna Iori, già docente di pedagogia in Cattolica, “in base ai dati Censis l'87 per cento dei ragazzi è connesso ad internet quasi tutto il giorno. Molti lo sono anche di notte. Per restare agganciati al mondo virtuale, l'unico in un periodo di distanza che ha messo a dura prova le relazioni”. Il 48, 9 per cento lamenta un mancato confronto con i docenti. L'80 per cento rileva come la mancanza più rilevante della scuola in presenza sia data dalla minore socialità con i compagni. Il 50,9 per cento lamenta per questo conseguenze negative sull'umore, sullo stato d'animo. È l'apice della solitudine sommersa. È la richiesta d'aiuto di una “generazione sospesa” che teme per il proprio futuro. I dati relativi ai tentati suicidi o all'ideazione suicidaria hanno subito un'impennata: siamo passati dal 10 all'80 per cento. A queste si aggiungono forme di “suicidio strisciante” quali i disturbi alimentari. “ È il simbolo di un disagio esistenziale che vuole chiudere una vita piena di dolore o che fatica a dare un nome alle emozioni. Alla rabbia, per esempio”. Ecco spiegato anche il forte aumento di risse. “Il vero problema sta in un diffuso analfabetismo emotivo, tanto in ambito familiare, quanto in ambito sociale e scolastico. Mai come oggi affiancare i giovani è un dovere educativo su cui tutti dobbiamo riflettere. Senza il senso del domani rischiamo che i ragazzi perdano lo scorrere della vita e riducano la capacità di guardare al futuro con entusiasmo”. Il sentimento prevalente oggi “è quello dell'ansia per il futuro. Si rende necessario un intervento che coinvolga tutta la comunità educante”.
Ascoltare per cambiare
Sono stati provati gli impatti delle emozioni negative sul processo di apprendimento. “I dati registrano un calo di apprendimento pari al 35 per cento” spiega il docente Severgnini. La maglia nera spetta a Puglia e Campania, regioni che hanno tenuti chiusi i cancelli delle scuole per più tempo. “Ecco perché ritengo che si debba valutare attentamente un'ulteriore chiusura delle scuole. La politica non può essere sorda. È richiesto un cambiamento, ed è richiesto subito. Servono patti educativi capaci di porre al centro i bisogni di tutte le persone che abitano la scuola. Serve aprire la scuola al territorio, superare la dicotomia tra il tempo dedicato all'apprendimento e quello dedicato alla socialità”. I giovani, con le parole di Giacomo Bertò, evidenziano come “sia stato strappato il lato emotivo della scuola. Voi adulti, per favore, ascoltateci. Se ci ascoltate passa l'ansia, passa la solitudine perché capiamo di non essere soli. Non ci serve qualcuno che ci assecondi, ma che capisca le nostre paure, i nostri disagi. Abbiamo bisogno che ci aiuti ad afferrare il presente”. Laurentiu Strimbanu della consulta provinciale ha spiegato la necessità di tutelare la scuola “come palestra di vita”. Una scuola che deve essere capace di includere. “Quello dell'inclusione è un dovere” ha detto la neuropsicologa Roberta Donini. E la scuola anche in questo periodo di forte cambiamento non può farsi trovare impreparata. Deve cambiare, elaborare nuove strategie, stringere nuove alleanze per consentire a tutti e a ciascuno di attivarsi. Di non subire. Di ascoltare, ascoltarsi e insieme continuare.