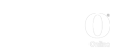Un semplice corpo di fabbrica con un piccolo portico. Spazio di preghiera sorto accanto ad un’immagine sacra, luogo di propiziazione e di benedizione per le attività agricole, zona di ricovero per i viandanti. La brezza è fresca e lo sguardo corre libero fino ad un’orizzonte montuoso. Luogo di pace, moderno e antico crocevia sulla strada per le Orobie. Siamo a Ricengo: la desinenza in -engo richiama l’origine Longobarda. Una piccola oasi ad oriente del fiume Serio, composta dall’unione di numerose località rurali. Ricca di insediamenti di epoca preistorica e romana, la prima menzione compare in un atto del’842 d. C: viene chiamato Cucingo. A metà dell’XI secolo passa dal vescovo di Bergamo a quello di Cremona. Nel 1097 il conte di Crema, Enrico e la moglie Belisia donano alcune terre di Ricengo al monastero di Montecassino, insieme alla chiesa cremasca di san Benedetto. Dal 1449 la storia del paese prosegue entro i confini dei domini di Venezia, a cui il Cremasco rimarrà aggregato fino al 1797.
Cautes Elicii
Facciamo un passo indietro. Torniamo al nome Cantuello. Dal latino ‘cautes’ , riva o terrapieno, zona paludosa dell’antico lago Gerundo. I ritrovamenti di piccoli reperti dell’età del bronzo, inducono a pensare che il luogo fosse abitato già in epoche remote. Le testimonianze della presenza di insediamenti di popolazioni in età romana offrono elementi per l’origine del nome ‘Cautes Elicii’ dalla presenza di un’ara dedicata a Giove. Oppure ‘Cautes Elelei per un’ara dedicata a Bacco. Tra le ipotesi sulle origini del nome la più convincente è quella elaborata su precisi ritrovamenti dal Parroco Don Mario Macalli nel 1954: il ritrovamento di una pietra incisa, forse la parte frontale di un altare dedicato ad Apollo Delius potrebbe dare luogo a successive trasformazioni dall’originario ‘in cavea delios’ e poi ‘incavetelius’ ed infine ‘Cantuelius’, da cui discende l’attuale ‘Cantuello’.
Il restauro che cura
Inizia oggi una nuova rubrica di Cremaonline, dedicata al recupero dei Beni culturali. Grazie alla collaborazione dell’architetto Magda Franzoni, dello storico dell’arte Matteo Facchi e della Diocesi di Crema, col delegato per i Beni culturali, don Andrea Rusconi, parleremo della “cultura del conservare, ossia del soccorrere il monumento affinché non raggiunga il limite oltre il quale non sia più possibile un suo utilizzo”. Racconteremo degli “interventi strutturali, realizzati in modo che i monumenti tornino a vivere e siano aperti al pubblico. Non una semplice manutenzione estetica”.
Salvaguardia e trasmissione
Faremo riferimento agli insegnamenti di Alois Riegel, alla “validità di tutto il costruito in quanto anello indispensabile dell’evoluzione storica, come arte, come storia, come segno del tempo trascorso, ma anche come patrimonio fisso per la comunità”. Troveremo conferma dei principi asseriti da Cesare Brandi: “il sito storico è un elemento di un ambiente naturale e monumentale che nei secoli, nonostante il forte degrado, non è stato profondamente alterato nei suoi dati spaziali, se non nella scomparsa di qualche elemento”. Il restauro conservativo si inserisce nel processo di salvaguardia e di trasmissione dell’opera architettonica al futuro. Il tutto avvalendosi delle teorie del restauro conservativo-scientifico nato dalle intuizioni di Camillo Boito e sintetizzate nella Carta del Restauro della Conferenza di Atene del 1931 e dalla Legge Italiana del 1939, del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche. Buona visione.
Cremaonline è su Whatsapp. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato in tempo reale.