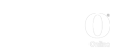Venerdì sera la luna nuova ha negato al pubblico di CremArena lo spettacolo della propria passerella nel retropalco. Dovremo attendere luglio per essere illuminati nel buio della notte estiva, ascoltando i prossimi relatori dei Manifesti. Eppure, nel silenzio assorto che accompagnava il discorso I quattro maestri di Vito Mancuso, si è acceso un altro tipo di segnale per sottolineare una presenza. Nell’introduzione Mancuso aveva ricordato che quel titolo rinvia ad un suo libro di cinque anni fa, dove l’ordine in cui i maestri vengono presentati non è cronologico ma emotivo. Socrate, Budda, Confucio, Gesù. E prima ancora di parlare di ciascuno di loro, ci regala una citazione da La vita della mente di Hannah Arendt: “Non è irrilevante notare come la parte immortale e divina nell’uomo non esista se non viene attualizzata e focalizzata su ciò che è divino fuori di lui; in altre parole, l’oggetto dei nostri pensieri conferisce immortalità al pensare stesso”. Quella frase, sottofondo dell’intero intervento, significa che se le nostre azioni e la nostra attenzione si volgono verso il divino che sta fuori di noi, ne viene potenziato ciò che di immortale e divino è presente dentro noi stessi. La mente umana è infatti capace di ospitare anche pensieri e azioni non finalizzati alla sopravvivenza biologica, ma tesi alla ricerca, alla creatività, alla giustizia e alla verità. Da qui nascono le religioni. E ciò in analogia con ciò che accade nella fisica quantistica, dove, secondo un noto scienziato, “i fenomeni fisici vengono costruiti attraverso la domanda che ci poniamo su di essi”.
Il maestro non è un erudito: trasmette significati
Dunque, che la parte immortale o divina di noi esista o non esista dipende dalle domande che ci poniamo. E chi attiva in noi il desiderio di porci domande? Il maestro, inteso non come colui che insegna conoscenze, ma che trasmette significati. L’erudito non è identico al saggio, chiosa Mancuso, ammiccando all’affezionato pubblico che lo segue nel succedersi delle stagioni a CremArena, e da bravo maestro rivolge a noi allievi la classica domanda di verifica: ricordate Kant? Che cosa posso conoscere? E che cosa posso fare? Critica della Ragion pura e Critica della Ragion pratica (ma il filosofo-teologo, nel libro del 2024 Destinazione speranza, non ha trascurato la terza Critica, quella del Giudizio: che cosa posso sperare?). Nell’accingersi a scrivere il libro sui maestri, Mancuso si è ispirato al testo di Jaspers I grandi filosofi. Le personalità decisive (1957), e ha qualificato ciascuno dei quattro con una specifica caratteristica. Per alleggerire i tecnicismi, l’essenza viene tradotta in fior fiore come quello di … beep, pubblicità. Socrate è educatore, Budda medico, Confucio politico e Gesù profeta. Di fatto abbiamo bisogno di ognuno di loro, che insieme producono una polifonia. Ma che cos’hanno in comune? Innanzitutto nessuno di loro ha scritto nulla. Ma fra loro il più “fortunato” è Socrate, poiché il testo fondamentale su di lui è stato composto non molto tempo dopo la sua condanna a morte nel 399 a. C. E ci viene rammentato che a condannarlo non è stato il governo filospartano dei Trenta tiranni, bensì la rinata democrazia ateniese. Il Vangelo di Marco, invece, vede la luce una quarantina d’anni dopo la crocefissione di Gesù. Secoli dopo la loro morte compaiono gli Analecta o Dialoghi di Confucio, e il Canone fondato su discorsi, parabole, sermoni e detti di Budda.
Il tafano e le cicale
Ma quale è stato quel segnale di una presenza a cui facevamo prima allusione? Che cosa si manifesta, quale è il segno che, da Sartre dell’Esistenzialismo è un umanismo (1945) al film di Shyamalan Signs (2002), vale a patto che ciascuno di noi gli attribuisca un significato? Sono cicale, sì, proprio le cicale dei miti narrati nei dialoghi platonici Simposio e Fedro iniziano a strepitare quando Mancuso presenta l’educatore Socrate. E accompagnano tutte le citazioni di Apologia in cui Socrate, di fronte a cinquecento ateniesi, assicura che mai cesserà di filosofare, né di ammonire i suoi concittadini a non inseguire ricchezze, occupandosi piuttosto di sapienza (sofia), verità (alétheia), anima (psyché). “Come noi qui, solo che voi siete circa quattrocento, e non mi condannerete a morte”, scherza Mancuso, abilissimo intrattenitore che ogni tanto lascia respirare gli allievi con una pausa di cui si assume la responsabilità: si toglie la giacca che ha indossato per noi, ma che ora non sopporta proprio più, con il caldo arroventato che la luce concentrata su di lui rischia di trasformare in incendio. L’immagine di Socrate si accomiata con quel tafano che stuzzica i concittadini troppo ricchi, dediti ad accrescere i beni materiali più che alla meditazione e alla conoscenza di sé. Qui il segnale si spegne, e il tafano se ne va insieme al canto delle cicale.
Il medico
Budda e Confucio, i meno noti. Qualche nozione su Budda, il medico che prova a lenire il dolore dell’uomo, potremmo recuperarla dallo studio liceale di Schopenhauer, quando il professore di filosofia spiegò le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero. O magari qualcuno in Città ha ricavato nozioni e insegnamenti sul buddismo, in occasione di incontri che ne illustravano l’attualità in un mondo dove la sofferenza è sempre sotto i nostri occhi, considerando le sconfinate possibilità di comunicazione degli odierni media.
Il politico
Confucio, il politico esperto dei vari Stati che ai suoi tempi componevano la Cina, descrive le tappe della propria esistenza, e accosta alla ricerca di un corso “senza tentennamenti” consigli etici indirizzati verso giustizia, lealtà, rettitudine.
Il profeta
Gesù, figlio di Dio, non viene raccontato come “colui che deve morire”, ma profeta del rinnovamento, di un nuovo mondo, quel regno di Dio che viene paragonato al granello di senape, al lievito, piccole cose che producono una realtà più grande ancora sconosciuta. Gesù insegna: “tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro”, precetto che ribalta in positivo il più noto “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Gesù è energia, forza per ricostruire un assetto di giustizia, solidarietà, amore. Oggi, in mezzo a venti di guerra, odio e disperazione di intere popolazioni, ce n’è davvero bisogno. Sia detto fra parentesi, nel libro Non ti manchi mai la gioia Mancuso ha chiarito che il “cristianesimo tradizionale di stampo paolino” è “ben diverso dal messaggio originario di Gesù”, definito gesuanesimo.
Il quinto maestro
Vito Mancuso non è un illuso sognatore. E non è un pensatore a senso unico, che chiude la porta a chi professa altre idee o altre religioni, né a chi si dichiara ateo o agnostico. Neppure intende tratteggiare a tinte fosche il declino del cristianesimo che è sotto gli occhi di tutti. Ha appoggiato su solide fondamenta un’esistenza di virtù e meditazione per familiarizzare sempre più con il quinto maestro: la coscienza. Questa non potrà venir meno, dovesse pure scomparire la religione cristiana come l’abbiamo conosciuta da piccoli. Kant? Sì, ma non solo: sapienza nel senso etimologico su cui si è soffermato il relatore. Dal latino sapio, sapĕre, aver sapore, essere saggio. Il saggio non è insipido. Il prossimo anno vedremo di che cosa sanno le ottocento pagine che Mancuso sta dedicando a Gesù.